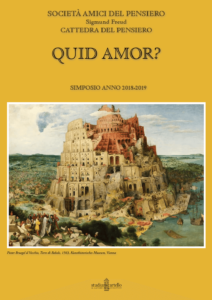 La nascita della parola “amore” non è un sicuro buon segno, introduce la tentazione a separare l’esperienza tra amore e diritto, sostanza e forma, concreto e astratto, cuore e mente, interiore e esteriore, emozione e rappresentazione:
La nascita della parola “amore” non è un sicuro buon segno, introduce la tentazione a separare l’esperienza tra amore e diritto, sostanza e forma, concreto e astratto, cuore e mente, interiore e esteriore, emozione e rappresentazione:
ne va, come in un divide et impera, della vita personale nelle formazioni collettive.
Il pudore dovrebbe riguardare l’amore non i sessi.
La parola “amore” non è primaria, nel miglior dei casi è un pleonasmo, un sinonimo fungibile.
Essa presuppone immediatezza (vedi “innamoramento”, secondarietà dell’atto, stregoneria (amore come fattura, malocchio), “datità” con una torva parola filosofica:
non designa l’artificio di un’arte da lavoro (propongo amor gratia artis come ars gratia artis), non è coniugata con la soddisfazione che risulta da un’elaborazione, si gargarizza con la parola “felicità”.
Parola di un’aspirazione a un presupposto successo illusorio, ha avuto successo come parola:
designante la miseria dell’amore platonico, figlio di due poveracci.
Possiamo però non disfarci della parola “amore” orientandola a designare l’appuntamento fatto regime e arte a ogni livello e caso, un’idea quasi assente nella corrente pratica povera del linguaggio:
il regime dell’appuntamento non è soggetto alla delusione dell’illusione.
Innamoramento, dono, politica di massa, usano e abusano della parola “amore”, il che almeno non fanno, con residuo pudore, produzione capitalistica e lavoro salariato con il loro sfruttamento: nel regime dell’appuntamento, favore con profitto, uno sottopone a sfruttamento l’investimento dell’altro.
La domanda quid amor? va associata alla domanda quid ius?, tradizionalmente affidata ai filosofi del diritto (non ai giuristi), mentre la prima lo è alla letteratura e alla canzone.
Giacomo B. Contri
Milano, sabato 1 settembre 2018
Pubblicato su societaamicidelpensiero.it

